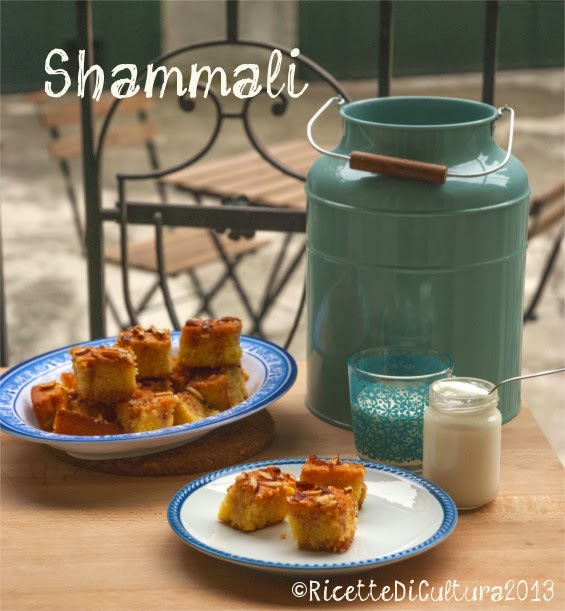Italia, paese di santi, poeti e navigatori… Navigatori appunto e anche marinai e pescatori, così come cuochi, per diretta conseguenza, che cucinano il pescato.
Il pesce, lungo le coste del nostro Stivale è cucinato in moltissimi modi diversi, ma un piatto si ritrova ovunque con alcune differenze che rendono l’assaggio una raffinata esperienza sensoriale, la zuppa di pesce.
Documentandomi per scrivere questo post ho scoperto cose che neppure immaginavo, avendo sempre vissuto sulla terraferma!! La cultura della zuppa di pesce è una vera e propria istituzione alle basi della cucina italiana.
Innanzitutto bisogna fare una distinzione tra il brodetto e la zuppa di pesce: il primo è diffuso lungo le coste di tutto l’adriatico, la seconda, con diverse varianti, allieta i palati lungo le coste del Tirreno.
Il piatto, come è semplice dedurre, era preparato per utilizzare l’invenduto dal mercato del pesce; nasce quindi come ricetta povera e di recupero, se di recupero si può parlare quando si tratta di pesce freschissimo. Di fatto ciò che si vendeva di più erano i pesci grossi, più facilmente utilizzabili in presentazioni eleganti alle mense dei nobili e ciò che rimaneva al popolo era la cosiddetta paranza: merluzzetti, triglie, piccole sogliole, crostacei di piccole dimensioni; molte volte a questi venivano aggiunti dei molluschi.
La preparazione è di solito colorata dal pomodoro, ovviamente ciò non avveniva prima della scoperta dell’America.
È affascinante scoprire le differenze tra i diversi brodetti e zuppe di pesce, viaggiando lungo le coste italiane.
A partire dall’alto Adriatico troviamo innanzitutto il brodetto alla triestina; secondo la ricetta il pesce va preventivamente fritto, prima di essere passato nel sughetto insaporito con aglio, cipolla e prezzemolo. Poi viene fatto riposare e riscaldato prima di essere portato in tavola.
A Venezia, precisamente nella zona di Caorle, troviamo il broeto ciozoto, tradizionalmente preparato in pentola di coccio su un fornelletto a carbone, direttamente sulle barche da pesca. Pare che al pescato misto, venisse preferito un solo tipo di pesce di laguna, il “go“, il ghiozzo.
Il brudèt ad pès è romagnolo, forse la prima ricetta tra tutte ad aver introdotto il pomodoro; essa prevede che ci sia anche qualche pesce a carne bianca, la gallinella, ad esempio, e consiglia lo Scorfano o il Coda di Rospo o il Pesce San Pietro.
Una menzione merita anche il brodetto di pesce alla fanese, marchigiano, che viene interpretato diversamente da famiglia a famiglia: vino bianco oppure aceto, pepe oppure peperoncino, aglio oppure cipolla, fanno sì che questa ricetta-non ricetta abbia un altissimo grado di personalizzazione.
In Abruzzo, a Pescara, coesistono due preparazioni a base di pesce; nel brodetto pescarese la base è fatta a crudo e man mano vengono aggiunti i pesci, dalle cotture più brevi a quelle più lunghe; nella zuppa il soffritto iniziale viene fatto a base di calamari e seppie e, particolare importante, assieme al pomodoro viene agiunto il peperone rosso tritato, dolce oppure piccante a seconda dei gusti. Anche la sequenza a tavola è diversa: la zuppa di pesce, accompagnata di fette di pane con l’aglio, è considerata un primo piatto, il brodetto può essere un primo oppure soppiantare un secondo.
Scendendo verso la Puglia incontriamo la Quatàra di Porto Cesareo, detta anche quataru ti lu pescatore o uatàra alla cisàrola, recentemente entrata a far parte dei PAT. La quatàra non è altro che il calderone di rame in cui viene preparato il sughetto in cui cuoceranno i pesci. Viene fatto rosolare insieme aglio, cipolla, prezzemolo e pomodorini, in poco olio d’oliva; il tutto si insaporisce in acqua di mare per circa due ore, poi viene aggiunto gradualmente il pesce, fino a 21 specie diverse. Il piatto viene servito con crostoni di pane fritti. La Quatàra è conosciuta anche come zuppa di pesce gallipolitana.
La zuppa di pesce siciliana prevede un’aggiunta di olive nere e di capperi al sughetto; in provincia di Catania, viene aggiunto anche un pugnetto di uva passa precedentemente ammollata.
In Sardegna il brodino succulento in cui si è cotto il pesce viene usato per lessare la fregola, un tipo di pasta di semola di grano duro che si può assimilare ad un cous cous a grana grossa. Così la fregola in brodo di pesce diventa il primo piatto e il pesce diviene il secondo.
La zuppa di pesce napoletana ha delle indicazioni molto precise riguardo ai pesci da utilizzare: immancabili sono scorfano, tracina e lucerna; si può fare a meno di gallinella o di pescatrice; a scelta possono essere aggiunti grongo oppure murena, piccoli calamari e polpo, molluschi ma sono se freschi e “veraci”.
Nel Lazio l’unica zuppa di pesce degna di nota è quella civitavecchiese, sfumata con il vino rosso e composta da una moltitudine di piccoli celenterati, crostacei e molluschi e l’aggiunta di scorfano e palombo.
Un discorso a parte merita il cacciucco livornese, vera e propria allegoria di un popolo. Negli ultimi anni del XVI secolo i Medici decisero di trasformare il piccolo villaggio di Livorno, sorto ai piedi della fortezza di Matilde, in una potenza mercantile. Emanarono le leggi Livornine (1590-1603) con le quali invitavano i
Mercanti di qualsivoglia Nazione, Levantini, Ponentini, Spagnoli,
Portoghesi, Grechi, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni,
Persiani a stabilirsi a Livorno con la promessa di avere un alloggio o
un magazzino o una bottega dove poter svolgere la propria attività e che
garantivano anche la cancellazione dei debiti, l’esenzione dalle tasse e
l’annullamento delle condanne penali. Da quel momento Livorno divenne ante litteram una città cosmopolita e multirazziale, ben rappresentata dalla mescolanza di pesci che compone il suo piatto più tipico, il cacciucco. Il pesce e il suo sugo vengono deposti su fette di pane abbrustolito ed agliato, che pare rappresenti un must per tutte le zuppe di pesce d’Italia.
Risalendo la penisola arriviamo alla Liguria e non si può concludere questo viaggio saporito, prima di aver assaggiato il ciuppin; il nome deriva da suppin, zuppetta, ma ha un suono bellissimo e onomatopeico che ricorda il pucciare del pane in questo sughetto succulento. Viene preparato in tutta la Liguria ed ogni famiglia ne possiede una ricetta personale. A Ponente i pomodori pelati sostituiscono i pomodorini freschi ed il soffritto iniziale viene fatto con carota,sedano, aglio e cipolla.
A questo punto vi chiederete che ricetta ho usato io per la mia zuppa. Una ricetta non ce l’ho, ma a guardar bene è un miscuglio di tutte queste usanze.
Per prepararla armatevi innanzitutto di pazienza, non solo perchè necessita di diversi passaggi, ma fin dal momento in cui andate al mercato per comprare il pesce, perchè “siete solo in due e no, non vi serve un chilo per ciascuna varietà di pesce che avete deciso di utilizzare”!
La mia versione è molto semplificata, in pratica si tratta di pulire le diverse varietà, preparare un fumetto di pesce, preparare il sughetto di pomodoro e infine cuocere il pesce.
La ricetta: Zuppa di pesce
250 g pomodori pelati
uno spicchio d’aglio
un peperoncino secco
vino bianco
300 g tra vongole e cozze
una decina di mazzancolle
3/4 seppioline medie
2 filettini di gallinella
1 nasellino
(di norma 2 piccoli scampi o 2 gamberoni per far scena)
fette di pane casareccio
aglio
Ho fatto spurgare le vongole immergendole in acqua salata e raschiato il guscio delle cozze. Poi ho fatto aprire entrambe in una grossa padella su fuoco vivace, conservando il fondo di cottura, (filtrandolo dalla sabbia, se occorre).
Ho preparato il fumetto di pesce, mettendo in acqua le teste delle mazzancolle e gli scarti del pesce, coprendoli d’acqua e portandoli a bollore con un rametto di prezzemolo e 1 spicchio d’aglio. Ho lasciato bollire per mezz’ora e poi ho filtrato il tutto ed unito al fondo di cottura dei molluschi.
In una pentola ho rosolato un grosso spicchio d’aglio e il peperoncino in 4 cucchiai d’olio, poi ho aggiunto il pomodoro tagliato a pezzetti. Ho aggiunto un po’ di brodo di pesce e fatto cuocere ed insaporire per circa mezz’ora. Poi ho aggiunto il pesce cominciando dalle seppie, che necessitano di una cottura più lunga, per finire con i crostacei e i molluschi.
Ho regolato di sale e aggiunto il prezzemolo tritato cinque minuti prima di spegnere il fuoco e servire.
Ho accompagnato con fette di pane tostato, strofinato con aglio e bagnato da un filo d’olio crudo.