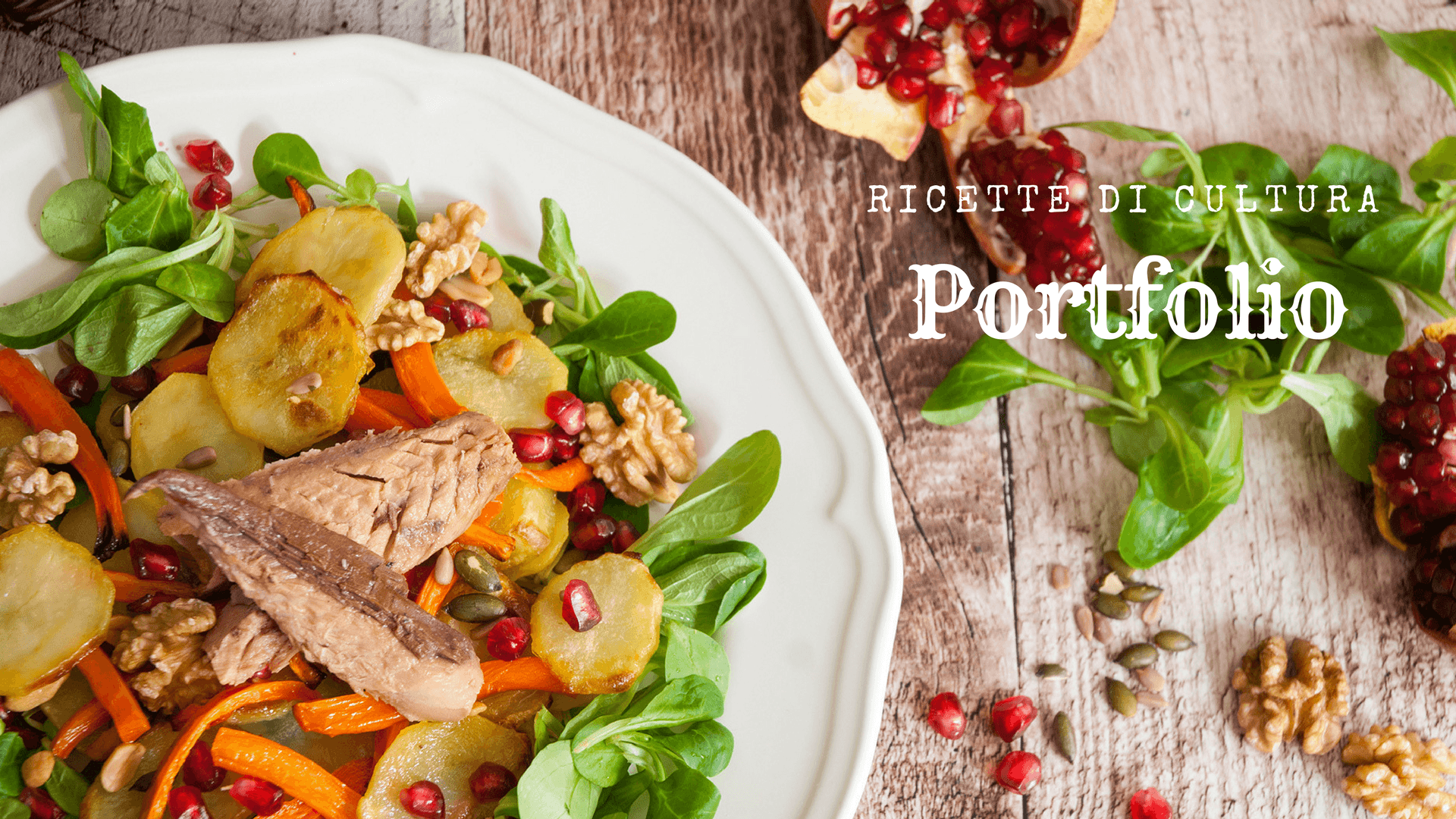La disputa su cantucci e biscotti di Prato è centenaria.
I primi, i cantucci, deriverebbero da un pane dolce all’anice, poi tagliato a fette e fatto tostare, per farlo conservare più a lungo. Nella forma e nell’aroma ricordano i genovesi biscotti del Lagaccio.
Quelli conosciuti come biscotti di Prato, invece, nella ricetta originale sono fatti con farina, zucchero, uova, mandorle e, talvolta, pinoli, senza alcun tipo di grassi né di lievito. Quindi sono ben croccanti e si prestano ad essere inzuppati nel vin santo, proprio perchè così asciutti ed essenziali.
La confusione legata al loro nome è però bilanciata da una storia antica e documentatissima.
I biscotti di Prato non sono nati a Prato, è la dura verità, derivano dai bischotelli fiorentini descritti da Francesco Redi, lo scienziato che ebbe il merito di inventare una deliziosa cioccolata al gelsomino per Cosimo de’ Medici nel XVII secolo.
Nel 1691 arriva la definizione dall’Accademia della Crusca: “biscotto a fette, di fior di farina, con zucchero e chiara d’uovo”, mentre la prima ricetta è effettivamnete custodita nell’archivio storico della città di Prato, risale al XVIII secolo e definisce questi biscotti come “fatti alla genovese”.
Un’altra disputa è legata all’abitudine consolidata di consumare questi biscotti in abbinamento con il vinsanto. I gourmet sostengono invece che in questo modo si danneggiano due prodotti, in primis il vinsanto che viene sporcato dalle briciole; in secondo luogo il biscotto che sembra necessitare dell’aroma del vino per poter essere gustato appieno.
Il dessert da fine pasto composto da vinsanto e cantucci è però innegabilmente ottimo, e rappresenta una gestualità lenta e antica, che mi ricorda le lunghe permanenze attorno alla tavola, una volta finito il pasto, nei giorni di festa.
Questi biscotti furono apprezzati da Herman Hesse, che li descrisse come gli unici tanto buoni da fargli tornare il buonumore, mentre Pellegrino Artusi racconta, ne “La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiare Bene”, del suo incontro con lo squisito e gentilissimo pasticcere
Antonio Mattei, papà dei biscotti di Prato dal 1858.
La storia di questi biscotti, l’avrete capito, è talmente estesa, documentata, controversa e ricca di colpi di scena da aver ispirato un libro, quello di Marco Ferri, “La vera storia dei cantucci e dei biscotti di Prato” dell’editrice Le Lettere.
La curiosità più simpatica sul nome di questi biscotti l’ho trovata su
coquinaria.it, dove vien detto che il nome “cantuccini” deriva dal fatto che i meno abbienti, pur di gustare questa delizia, si accontentavano delle parti terminali del filone, i cantucci appunto, considerati meno pregiati delle fette centrali. In realtà i linguisti forniscono una spiegazione meno romantica: pare derivare da
cantellus che in latino significa pezzo o fetta di pane.
Il punto è che quella dei cantucci-biscotti di Prato è anche una tecnica, tanto geniale, quanto estendibile anche ad impasti leggermente diversi, più ricchi, e si rivela una vera alleata per preparare degli ottimi biscotti senza dedicare molto tempo al taglio della forma.
In più le possibilità di variazione nel gusto sono infinite: canditi, cioccolato a pezzettini, altra frutta secca…
Io li ho preparati con la farina di grano saraceno, ultimamente mia grande alleata in cucina, e con l’aggiunta di noci ed arachidi all’impasto.
La ricetta: Biscotti con farina di grano saraceno, arachidi e noci
120 g di farina di grano saraceno
80 g di farina bianca tipo 0
120 g di zucchero
80 g di burro
1 uovo
1 pizzico di sale
60 g di gherigli di noci
100 g di arachidi sbucciate
la punta di un cucchiaino di lievito in polvere per dolci
Ho lavorato il burro con lo zucchero, ho aggiunto l’uovo sbattuto con un pizzico di sale ed ho mescolato bene il tutto.
Ho aggiunto gradualmente le farine e successivamente il lievito in polvere.
Per ultime ho inserito nell’impasto la frutta secca sbriciolata grossolanamente.
Ho lasciato riposare questo impasto per circa mezz’ora al fresco.
Ho composto sulla carta da forno dei filoncini, spessi circa 5 cm, ed ho infornato a 170° per circa 15/20 minuti.
Quando i filoncini erano tiepidi li ho tagliati a fette, leggermente in diagonale, dello spessore dei 1,5 cm.
Ho nuovamente infornato le fette di biscotto finchè non erano leggermente dorate.